Il racconto:
“Quando avevo trent’anni, la mia azienda pagava lo stipendio per contanti. Passava un commesso in divisa col carrello e mi consegnava una busta marroncino chiaro.
Firmavo per ricevuta e intascavo il denaro con un doppio sentimento di riconoscenza: quello che mi veniva attribuito mi bastava per il presente (ero persona sobria) e assumeva pure un risvolto aggiuntivo, poiché il trattamento previdenziale in vigore mi avrebbe assicurato una vecchiaia dignitosa.
Nessuno di noi aveva, allora, gli strumenti per prefigurare quale sarebbe stata la rendita differita: avevamo però la consapevolezza che, a prescindere dalla carriera luminosa che ci attendeva, il vitalizio si sarebbe probabilmente avvicinato quasi al 67% dell’ultima retribuzione.
E poi, c’era sempre il paracadute del welfare che si preoccupava della nostra salute, con un’efficace assistenza sanitaria, per noi e i parenti più stretti, e il volontario Fondo Pensioni Comit, tra i primi esempi del genere in Italia, retaggio della tradizione mitteleuropea della banca nella quale operavo, che avrebbe integrato, al momento opportuno, la rendita INPS.
Era il 1970 e il rapporto tra lavoratori e pensionati era, in Italia, di circa 7,5 lavoratori per ogni pensionato. Questo significava che per ogni pensionato c’erano 7,5 persone in attività lavorativa che contribuivano al sistema pensionistico. Da allora, questo rapporto è diminuito drasticamente. Secondo gli ultimi dati disponibili (fine 2023), quel rapporto è pari, adesso, solo all’1,49.
Ripetiamolo assieme ad alta voce, perché questo è un dato spaventoso: ci sono appena 149 occupati per ogni 100 pensionati, mentre in Germania, altro Paese con un’altissima età media, il rapporto è 179 e in Spagna ancora di più, 204.
Perciò, se avessi di nuovo i miei trent’anni (magari…ma non certo per il profilo previdenziale) andrei prima di tutto a leggermi il rapporto demografico dell’INPS sullo stato del Paese, che registra i seguenti dati: 59 milioni scarsi di residenti al 1° gennaio 2025, in calo dello 0,6 per mille sull’anno precedente. Nel 2024, le nascite sono state circa 370.000, segnando una diminuzione del 2,6% rispetto all’anno precedente, mentre i decessi sono stati circa 651.000. Questo porta a un saldo naturale negativo di 281.000 unità, che si traduce in una diminuzione netta della popolazione complessiva. Va segnalato, inoltre, che la popolazione femminile nell’età convenzionalmente considerata riproduttiva (15- 49 anni) è passata da 14,3 milioni di unità al 1° gennaio 1995 a 11,4 milioni al 1° gennaio 2025.
E meno male che, al 1° gennaio 2025, i residenti di cittadinanza straniera sono ammontati a 5 milioni e 422mila unità, in aumento di 169mila individui (+3,2%) sull’anno precedente, con un’incidenza sul totale del 9,2%.
Occorre, perciò, effettuare un breve excursus sulla valenza degli stranieri residenti in Italia. che contribuiscono alla tenuta non solo del tessuto produttivo, ma anche del sistema di protezione sociale. Le idee che alcune forze politiche tendono ad accreditare sulla equivalenza tra stranieri residenti (largamente maggioritari) e richiedenti asilo, rappresentano una strumentale sgrammaticatura.
Partiamo, ad esempio, dalle imposte sui redditi pagate dai cittadini stranieri presenti in Italia (fonte: dossier statistico immigrazione IDOS. Le elaborazioni sono, purtroppo, abbastanza datate (risalgono al 2019. Non tengono quindi conto degli effetti della pandemia, ma sembrano comunque utili).
La voce di entrata più importante era rappresentata dai contributi previdenziali obbligatori, calcolati sulla base del numero e delle retribuzioni medie dei lavoratori forestieri.
Il totale dei contributi versati da quel ceto risultava pari a circa 15,4 miliardi di euro, cifra che si avvicinava quasi al 7% del totale dei contributi incassati dall’Inps in quell’anno (218 miliardi; fonte: bilancio INPS 2019).
Seguiva l’Irpef, con un gettito specifico di 5 miliardi (fonte: Ministero dell’Economia), inferiore a quello dei contributi perché tanti stranieri risultavano incapienti a causa dei bassi redditi. Però, parliamo pur sempre di cinque miliardi. È interessante osservare che, tra il 2014 e il 2019, il numero dei contribuenti nati all’estero era cresciuto del 16,9 per cento; per contro, il numero dei contribuenti nati in Italia era salito, nello stesso quinquennio, solo dell’1,6 per cento.
Non siamo lontani dal vero se osserviamo che, nel 2019, gli stranieri residenti avevano concorso al bilancio statale con un gettito superiore ai venti miliardi.
Torniamo, con un salto, al 2025: siamo tra i Paesi con meno lavoratori registrati sul totale della popolazione, e allo stesso tempo tra i Paesi più anziani; significa che ci sono sempre meno occupati, idonei a creare le risorse necessarie per pagare sia le pensioni di chi ha smesso di lavorare, che le altre, le pensioni sociali.
E nel futuro? La Ragioneria di Stato prevede (secondo noi, molto ottimisticamente), secondo i suoi parametri demografici, una soglia per la pensione di vecchiaia a 67 anni e 5 mesi nel 2030, a 68 anni e 1 mese nel 2040.
Curiosi come siamo (nel 2040 saremo ancora freschi e pimpanti), verificheremo di persona se l’avranno “azzeccata”.
Crediamo però che senza il concorso, talora in parte grazioso (tanti stranieri vanno via senza aver maturato i requisiti minimi e, quindi, ci regalano i loro contributi), la soglia pensionistica sarà allora superiore ai settanta anni.
E riferiamo, da ultimo, che il 53,5% delle pensioni presenta, mentre scriviamo, un importo inferiore ai 750 euro. Insomma, non c’è molto da scialare.
Altro che commesso col carrello che passava tra le scrivanie di Piazza Scala, promettendoci una vecchiaia dignitosa! Quello, è un ricordo che va svaporando nelle nebbie meneghine (che poi, anche loro, sono malinconicamente scomparse da decenni nella metropoli lombarda, assieme alle buste marroncine coi contanti).“
Enzo Barone
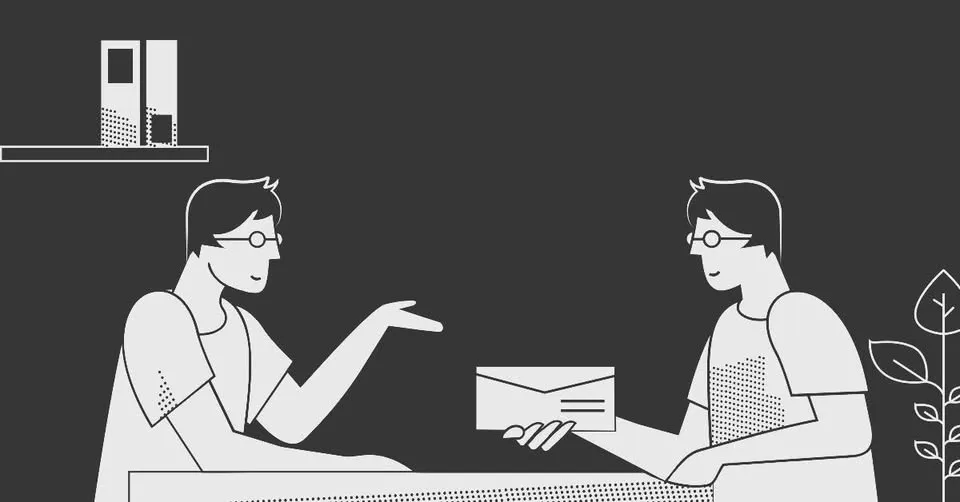




Scrivi un commento